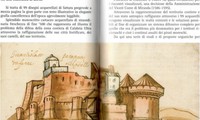Maida - Il Codice Romano Carratelli: storia di un collezionare
Venerdì 23 Marzo 2018 12:03 di Redazione WebOggi.it
L’ associazione culturale La Lanterna sabato 17 marzo nei locali della biblioteca scolastica di Maida.ha presentato il Codice Romano Carratelli Sono intervenuti: la prof.ssa Giorgia Gargano docente di Materie letterarie ed ispettore onorario per i beni numismatici della Calabria, la prof. ssa Giovanna De Sensi, ordinario di Storia greca all'Università della Calabria, l'on. avv. Domenico Romano Carratelli proprietario del Codice " giudicato dalla stampa e dagli studiosi come la scoperta storico-culturale più importante della Calabria dopo i Bronzi di Riace e per cui la Regione Calabria ha chiesto all’UNESCO la iscrizione nel registro della “MEMORIA DEL MONDO”.
E’ stato un appuntamento di grande interesse culturale che ha visto la presenza oltre che delle istituzioni con il primo cittadino di Maida dott. Salvatore PAONE di molte personalità della cultura calabrese.
Leo Greto Ciriaco
Una breve descrizione del codice
"si tratta di uno splendido manoscritto cartaceo di fine ‘500 che rappresenta ed illustra il problema della difesa della zona costiera di Calabria Ultra attraverso la raffigurazione delle sue città fortificate, dei suoi castelli, delle sue torri e del suo territorio. In particolare vi vengono riportate le tipologie e le caratteristiche delle torri esistenti ed in costruzione individuando, altresì i luoghi ove era necessario la costruzione di nuove torri per le quali viene redatto il progetto ed indicata la possibile spesa. La rappresentazione delle torri è corredata da note illustrative minuziose e descrittive dei luoghi, dei posti, delle distanze, delle tipologie costruttive, dei costi, dei torrieri e dei cavallari oltre talvolta accenni ai Signori del posto, a chi ne aveva ordinato la costruzione nonché ai costruttori e quindi ricche di notizie assai utili agli studi per i necessari riscontri documentali Del Codice non si conosce, allo stato, il nome dell’autore: ma di esso molto si discute e sono state avanzate alcune ipotesi. Si può ragionevolmente pensare che l'opera, miracolosamente riapparsa dopo oltre quattrocento anni, sia rimasta ignota in quanto copia unica e secretata dal Governo Vicereale del Regno di Napoli per motivi di sicurezza. Il Codice, e per esso i 99 acquerelli, sono una scoperta assoluta e suggestiva, quasi fotografica, di un tempo storico di cui non avevamo se non qualche raro ed occasionale disegno e rappresentano pertanto la più antica iconografia di cui può disporre la storiografia calabrese per il territorio costiero, e non solo, della Calabria Ultra". Prof. Saeli
Relazione della dott.ssa Giorgia Gargano
Del codice Carratelli parlerà la professoressa De Sensi Sestito, quindi io mi limiterò a introdurre l'introduzione per parlare di un contesto nel quale l'esperienza di passione antiquaria e collezionistica legata al Codice si dipana. Da quando sono venuta a conoscenza dell'esistenza del codice ma soprattutto delle modalità con cui il suo attuale possessore, l'onorevole Romano Carratelli, ne dà instancabilmente diffusione, non ho potuto sottrarmi dall'inquadrare questa - che è già una storia sensazionale per la qualità dell'oggetto di cui parliamo - nella più ampia e gloriosissima storia del collezionismo vibonese. Che si è connotato, specialmente ab origine, per una grande sensibilità alla diffusione delle collezioni. Il che non è scontato, se consideriamo che la storia del collezionismo settecentesco nasce e si diffonde come passione privata con cui intrattenere e decorare le abitazioni nobiliari di oggetti che destassero, prima di ogni cosa, meraviglia e curiosità: parlo delle cosiddette wunderkammern, che non mancavano nei palazzi degli aristocratici che volessero esibire la propria erudizione. La storia del collezionismo come possibile azione di una politica "alta" invade anche la storia dell'istruzione quando sia ispirata a un sentimento di condivisione e adoperata come strumento di crescita culturale di una comunità: pensiamo ad esempio alla collezione di epigrafi che Galeazo Capialbi, antenato del più celebre conte Vito, affisse all'esterno delle pareti del proprio palazzo monteleonese nel 1514 e che viene considerato il più antico museo lapidario d'Italia. Perché questo evento sia significativo e perché si colleghi alla storia del Codice è presto detto: Galeazo Capialbi non si accontentava del possesso degli oggetti: li espose perché diventassero un patrimonio comune, un patrimonio della sua città. In questo percorso che parte da Monteleone (il nome antico della città di Vibo) e termina alla Vibo Valentia di oggi ho pensato di farmi accompagnare dalle parole stesse dei collezionisti ma soprattutto dal padre di tutti i collezionisti di antichità italiane, Sir William Hamilton, la cui biografia è stata romanzata da Susan Sontag ne "L'amante del vulcano". Il Cavaliere è stato ambasciatore d'Inghilterra alla corte di Napoli dal 1764 al 1800, negli anni in cui fervevano le prime pionieristiche ricerche su Pompei - individuata per la prima volta nel 1738 - e, ahinoi, anche le prime alacri attività del commercio più o meno clandestino dei reperti archeologici in partenza dall'Italia verso le grandi città nordeuropee. La straordinaria collezione di Sir William Hamilton - fatta di reperti archeologici e monete antiche ma anche di fossili, quadri, minerali e ogni genere di oggetti artistici che solleticassero l'onnivora curiosità del nobile inglese - andrà quasi del tutto perduta a causa del naufragio della nave Colossus che da Napoli doveva spostare in Inghilterra il museo privato di Hamilton. Spero dunque che l'on. Carratelli vorrà seguirmi e alla fine raccontare quanto di sé possa esserci tra i diversi ritratti di collezionisti che, talvolta anche con un po' di umorismo, emergeranno da questa analisi. Partiamo intanto dal definire, con le parole di Susan Sontag, chi sia il collezionista e quale sia una delle possibili relazioni tra se stesso, l'oggetto e il denaro: "Il dolce fato del collezionista (o di chi crea un gusto… Ma gli arbitri del gusto sono di solito collezionisti): essere in anticipo sugli altri e, quando gli altri si mettono alla pari, essere escluso, a causa del prezzo, dal competere per ciò che hanno scoperto. (E può finire con l'apparire meno desiderabile, perché ora interessa troppi.) Lui - perché di solito è un lui - si imbatte in un oggetto sottovalutato, trascurato, dimenticato. Sarebbe troppo chiamarla una scoperta; chiamatelo riconoscimento. (Con la forza, la gioia di una scoperta). Comincia a farne collezione, o scriverne, o entrambe le cose. Grazie ai suoi sforzi di proselitismo, molti trovano ora interessante o pregevole ciò che non attirava l'attenzione di nessuno o che a nessuno piaceva. Altri cominciano a farne collezione. Diventa più costoso". "Quel fremito, nell’attimo in cui lo adocchi. Ma non dici niente. Non vuoi che l’attuale proprietario si accorga del valore che ha per te. E non vuoi far salire il prezzo o fargli decidere di non vendere affatto. Così fai l’indifferente, esamini qualcos’altro, ti allontani o esci, dicendo che tornerai. Reciti fin in fondo la commedia di chi è interessato, ma non troppo; incuriosito sì, magari tentato, ma non sedotto, stregato. Non certo disposto a pagarlo anche più di quanto è stato chiesto, perché devi averlo. Il collezionista è perciò un simulatore, qualcuno le cui gioie non sono mai disgiunte dall’ansia. Perché c’è sempre qualcosa di più. O qualcosa di meglio. Devi averlo perché è un passo ulteriore verso un completamento ideale della tua collezione. Ma questa completezza ideale che il collezionista agogna è una meta illusoria". Il primo grande collezionista vibonese è il conte Vito Capialbi che, come Sir Hamilton, ha collezionato di tutto e ha costruito una cultura del collezionismo locale: Vito Capialbi ha avuto sin da subito ben chiaro il valore del collezionare, in un periodo in cui questo significava salvare dall'esportazione i reperti archeologici come i documenti d'archivio o i libri o i quadri e mantenerne il collegamento con il territorio di provenienza. Se il giovane Vito Capialbi (che nasce a Monteleone nel 1790 e vi muore nel 1853) racconta di aver iniziato i suoi studi all'indomani del fallimento della politica napoleonica in Calabria, cioè all'indomani della morte di Gioacchino Murat a Pizzo, contemporaneamente è consapevole di operare politicamente mentre ridà dignità alla propria terra attraverso la materializzazione della propria storia, che avviene, per l'appunto, attraverso la raccolta, lo studio, l'edizione degli oggetti. Scrive Vito Capialbi in una lettera del 1830 a Francesco Carelli, grande studioso e collezionista napoletano: "Che ne dice S.V. di questo ardimentoso progetto di uno scioccarello, il quale si giace nell'estrema Calabria senza libri et toto divisius orbe? Se nol gradisce, il compatisca almeno, giacché non altro che compatimento possono sperare gli uomini di basse conoscenze, come io sono". Qual è questo "ardimentoso progetto"? E' l'edizione della sua collezione di monete: c'è in Capialbi un vigore generoso, un afflato amoroso verso la propria terra: non c'è in lui traccia della gelosia e del senso del possesso degli oggetti. Il collezionare è per lui prodromo di un'apertura non narcisitica, ma direi didattica: perché la sua attività abbia un senso storico, è necessaria la sua diffusione. Per il collezionista, poi, c'è il problema del luogo in cui tenere i propri amati oggetti, che, per lo più, devono essere accessibili, ispezionabili, tangibili sempre. Hamilton, per esempio, aveva due facce, che corrispondevano ai due livelli del palazzo in cui erano custoditi i suoi reperti; c'è il Cavaliere del primo piano e il Cavaliere sottoterra. provate a immaginare con me... "Il Cavaliere al primo piano, oltre la prima anticamera, dove chi lo visitava per affari restava in attesa di un po’ della sua attenzione: nel suo studio. La stanza appariva ingombra, disordinata. Terrecotte e intagli antichi sui tavoli; campioni di lava, cammei e basi nelle vetrine; ogni centimetro delle pareti coperto di quadri, compreso quello attribuito a Leonardo, e di gouaches del Vesuvio in eruzione di artisti locali. E telescopi alla finestra puntati sul Golfo. Il motto iscritto in oro in cima a una parete, sotto la cornice, “la mia patria è dove mi trovo bene“, toccava la giusta nota d’insolenza. Qui il Cavaliere trascorreva la maggior parte della giornata, in adorazione dei suoi tesori. Le loro forme, scrisse, sono semplici, belle e variegate più di quanto si possa descrivere. Il Cavaliere sottoterra, nei sotterranei del tesoro, il suo “ripostiglio“. Qui si trovavano i vasi scartati, i quadri in avanzo e un guazzabuglio di sarcofagi, candelabri e busti antichi troppo restaurati. E oltre a oggetti di qualità inferiore, giudicati immeritevoli di essere esposti, il Cavaliere conservava qui quei pezzi antichi che al Re e ai suoi consiglieri non sarebbe affatto piaciuto sapere in mani straniere. Mentre a tutti i visitatori illustri venivano mostrati gli oggetti nello studio del Cavaliere, pochi erano coloro ai quali si faceva fare un giro dei depositi sotterranei. Ogni collezionista è potenzialmente (se non di fatto) un ladro". Dalla perizia redatta all'indomani della morte di Vito Capialbi apprendiamo che le collezioni del Conte erano razionalmente esposte nel palazzo di famiglia, ancora oggi nei pressi del castello normanno svevo di Monteleone; in parte si trovavano in posizioni tali che lui potesse accedervi e studiarle. In ogni caso, dalla sola descrizione che abbiamo di quella sistemazione, emerge con certezza la cura e la sistematicità. Tant'è vero che la collezione, tranne che per qualche dettaglio, si è conservata. Diverso è invece il caso del secondo grande collezionista monteleonese a cui accennerò: il barone Domenico Antonio Cordopatri. Di una generazione più giovane di Capialbi, inizia a collezionare con l'intento dichiarato di coprire i vuoti della Capialbi e di creare una sorta di ricettacolo di tutti i reperti archeologici e delle monete che emergevano dal circondario e dovevano essere piazzati sul mercato. Di nuovo parliamo di un'azione di tutela del proprio territorio di appartenenza. Purtroppo però il Cordopatri, a differenza di Capialbi, non era uno studioso, ma una sorta di accumulatore seriale. Così descrive la collezione François Lenormant, uno dei pochi ad averla potuta visionare: «Ho potuto studiare con cura la collezione del signor Cordopatri, il quale è anche lui uno dei Patrizi della città, ed al presente colui che ne raccoglie le antichità. E questo esame mi ha fornito la materia di molte utili osservazioni. Lì pure vi è di tutto; un guazzabuglio completo di che fornire copiosamente un magazzino di curiosità. Libri antichi, manoscritti, fasci di diplomi su pergamena sono ammucchiati a montagne, tra le quali si può appena circolare, in certe sale del piano superiore del palazzo del signor Cordopatri, il quale si scusa dello stato di disordine della sua collezione, causato dalle riparazioni all'edificio, che lo hanno costretto a sgombrare ogni cosa, accatastandola alla rinfusa; per un danno al tetto, molti oggetti sono stati sciupati dagli stillicidi prodotti dalla pioggia. Egli è, del resto, di una perfetta cortesia per aiutarvi a rovistare nel suo caos e per elargirvi ogni facilità di lavoro che possiate desiderare». La collezione Cordopatri ci introduce a un terzo tema fondamentale del collezionismo: la fine della collezione. Non parlo della completezza della collezione, per la quale mi affido di nuovo alle parole di Susan Sontag: Una collezione completa è una collezione morta. Non ha avvenire. Dopo averla formata, l'ameresti ogni anno di meno. Non passerebbe molto tempo e vorresti venderla o donarla, e imbarcarti in una nuova caccia. Le grandi collezioni sono vaste, non complete. Incomplete: motivate dal desiderio di completezza. C'è sempre qualcos'altro. Una grande collezione privata è un concentrato materico che stimola continuamente, che sovreccita. Non soltanto perché può essere sempre accresciuta, ma perché c'è già troppo. Il bisogno del collezionista è precisamente quello di eccesso, sazietà, profusione. È troppo - e mi basta appena. Chi esita, chi chiede: "Ne ho proprio bisogno? Mi è veramente necessario?" non è un collezionista. Una collezione è sempre più del necessario. Le grandi collezioni setteottocentesche sono state per lo più disperse dalla distrazione degli eredi: quasi mai sono menzionate nei testamenti, restano tra il patrimonio indiviso - e spesso nell'indifferenza e nella noncuranza di chi se le trova da gestire insieme a terreni, argenterie e palazzi. La collezione Cordopatri, per esempio, è stata completamente dispersa dagli eredi, tanto che praticamente nulla ne è recuperabile sul piano della memoria. Il Marchese Enrico Gagliardi (1896-1953), il terzo grande collezionista monteleonese di cui parliamo, ha prevenuto il rischio della dispersione: a ricordo della sua profonda amicizia con Paolo Orsi, che lo aveva soprannominato "il marchesino", Gagliardi ha donato, per lascito testamentario, la sua importante collezione numismatica di oltre 1000 monete antiche al museo archeologico di Siracusa - dove oggi è magnificamente esposta. Una collezione, questa volta, costruita anche con pezzi acquistati per la loro bellezza sul mercato antiquario - e dunque non così strettamente legata alla storia dei luoghi come le due precedenti e il cui scollamento è stato accentuato dalla decisione di spostarla dalla Calabria, che forse sarebbe stata la sua sede naturale... Certe volte studiamo la storia che si è fatta; davanti all'on. Carratelli confesso di provare ogni volta la sensazione della storia mentre si fa. Susan Sontag fa dire al suo Hamilton: DIA Le collezioni uniscono. Le collezioni isolano. Uniscono coloro che amano la stessa cosa. (Ma nessuno ama quanto me; abbastanza.). Isolano da chi non condivide la passione. (Ahimé, quasi tutti). Allora cercherò di non parlare di ciò che mi interessa di più. Parlerò di ciò che interessa a te. La diffusione della conoscenza del codice Romano Carratelli è meritoria: ciascuno di noi vi troverà quello che gli interessa, dal generale al particolare, dalla storia della rappresentazione della terra alla storia di un singolo luogo calabrese. Spero però di avervi sollecitato su un dettaglio: la storia delle collezioni non è mai solo una storia di oggetti. E' una storia, più o meno onorevole, di uomini.